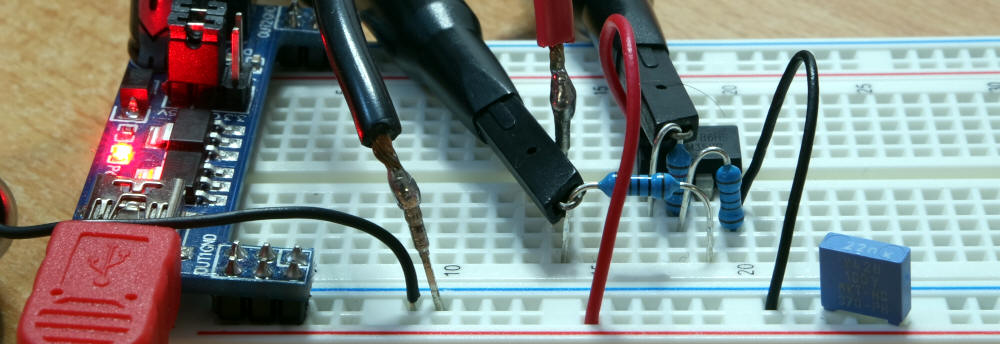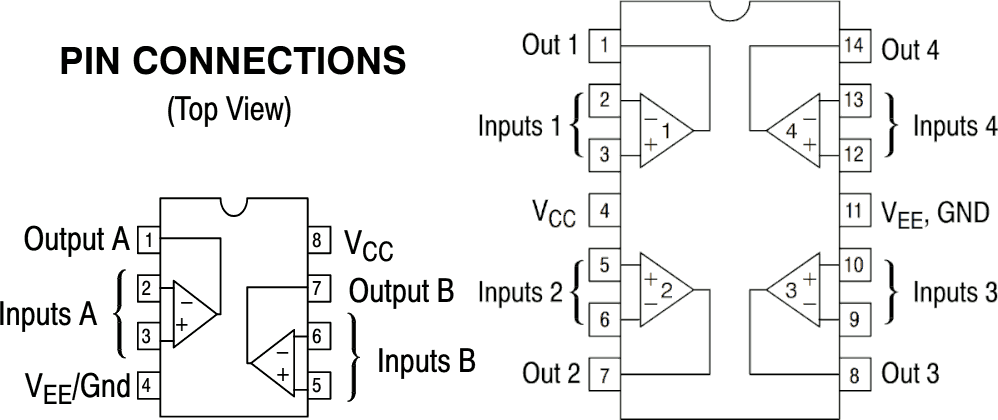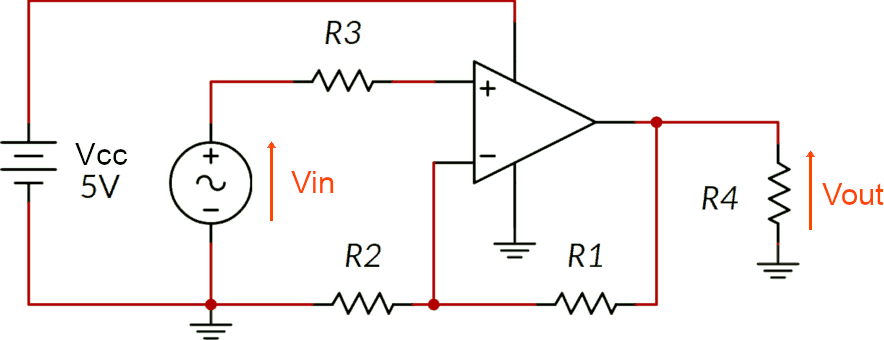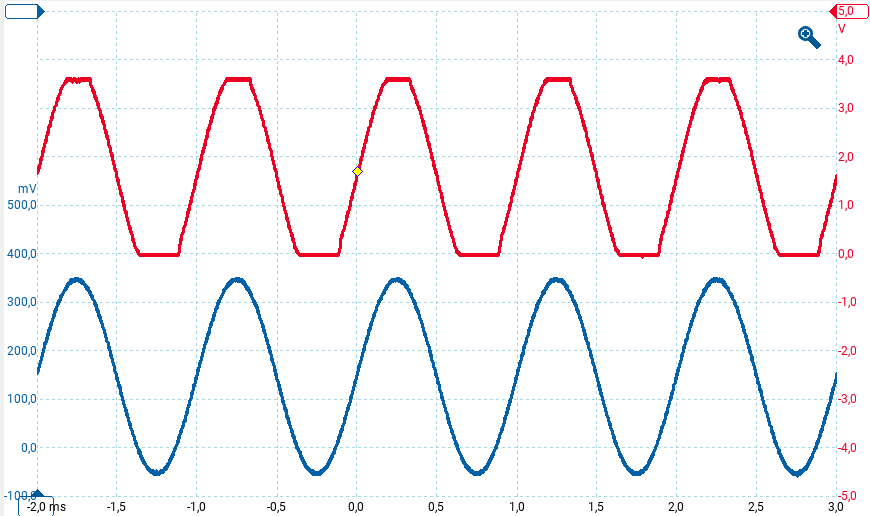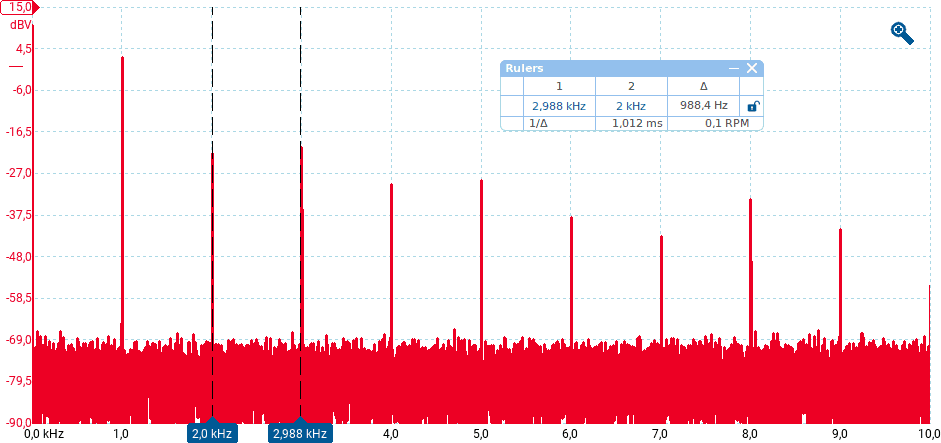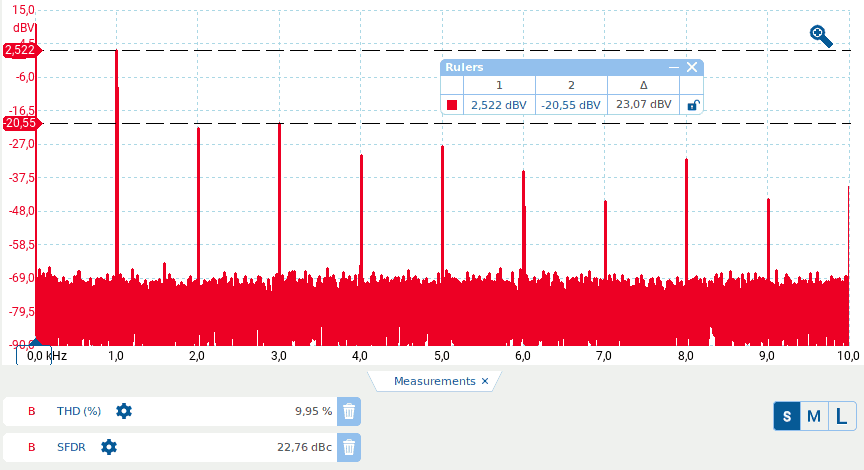Home →
Tutorial →
Appunti scolastici → Quadripoli
→ Amplificatori → Laboratorio: amplificatore operazionale
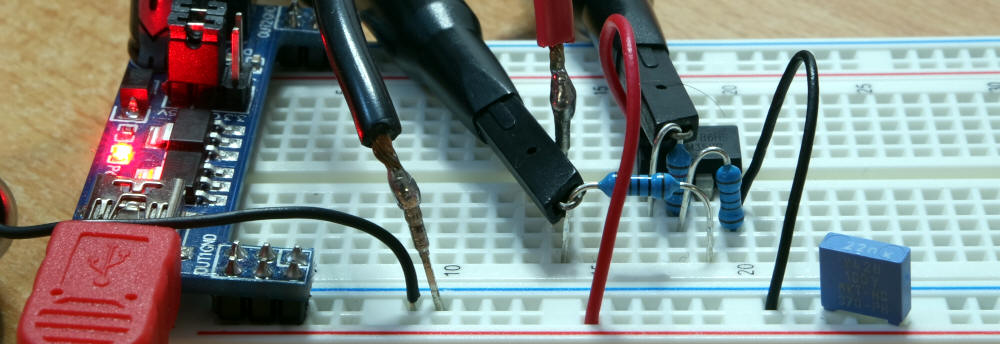
In questa pagina analizzeremo un semplice
amplificatore per
piccoli segnali realizzato utilizzando un
amplificatore operazionale.
Utile, prima di proseguire, aver effettuato le attività descritte nella pagina
simulazione di amplificatori.
I fogli tecnici
Preliminare alla realizzazione del circuito dovrebbe essere l'individuazione
dell'amplificatore operazionale più adatto: purtroppo i criteri da esaminare ed i
modelli presenti sul mercato sono un'infinità e non verranno quindi qui discussi.
Spesso la scelta in ambito scolastico oppure hobbistico è
banale: si prende un amplificatore operazionale qualunque tra quelli disponibili...
Di seguito si farà riferimento a
LM358 (operazionale doppio)
oppure LM324 (operazionale
quadruplo), dispositivi per usi generali con prestazioni tutt'altro che elevate,
ma molto diffusi e, soprattutto, adeguati a funzionare con una alimentazione
singola (nota 1).
Nei fogli tecnici è
presente la piedinatura dell'amplificatore operazionale effettivamente
utilizzato, qui riportata per LM358 (a sinistra) e LM324 (a destra):
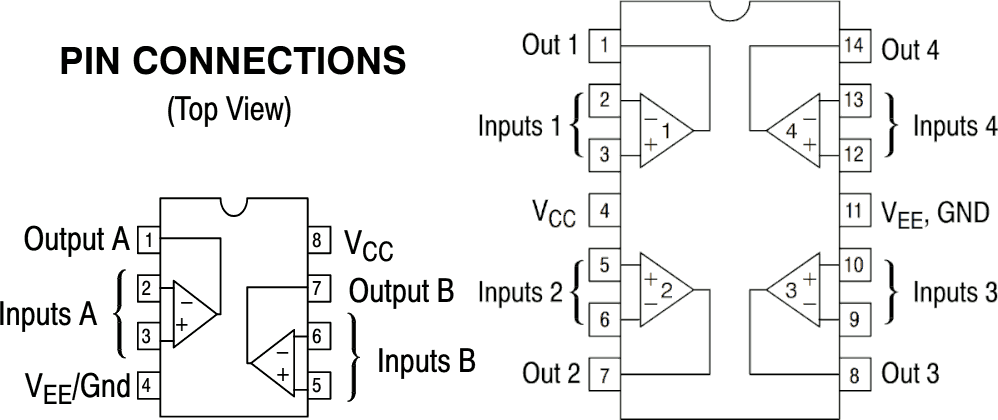
Come attività avanzata possono essere consultati alcuni
aspetti presenti nei fogli tecnici del componente utilizzato (LM358
oppure LM324):
- tra i valori massimi assoluti (distruttivi!): tensione massima e
minima in ingresso e di alimentazione
- tra i valori raccomandati: tensione di alimentazione minima e
massima (nota 2)
- tra le caratteristiche: tensione di uscita minima e massima
- tra le caratteristiche: corrente massima di source (che esce dall'uscita) e di
sink
(che entra nell'uscita)
Il circuito
L'amplificatore da realizzare è costituito da un amplificatore
operazionale e da alcune resistenze.
Sono inoltre presenti due
generatori di tensione
- l'alimentazione Vcc, sempre continua e, nell'esempio qui
mostrato, pari a 5 V
- un segnale
di ingresso Vin, normalmente sinusoidale e fornito da un
Generatore di Funzioni
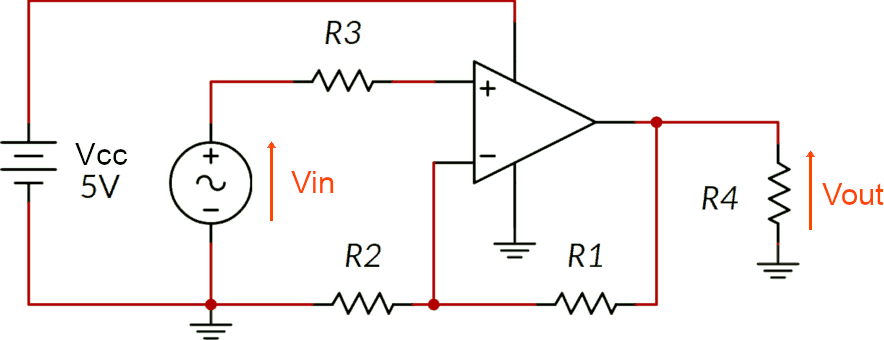
Questo amplificatore è un amplificatore non invertente. Il nome indica che la
tensione di uscita (Vout) è maggiore di quella di ingresso (Vin) e che ha lo
stesso segno. Si può
dimostrare
che il
guadagno di tensione dipende solo (o quasi) dal valore di R1 e R2, secondo
la formula:
G = Vout / Vin = 1 + R1 / R2
Alcune note sulla scelta delle resistenze e dei generatori:
- la tensione di alimentazione Vcc può essere diversa da 5 V,
tipicamente maggiore, ma deve
essere compatibile con le informazioni contenute dei fogli tecnici
- non ci sono vincoli particolari per il guadagno anche se, per quanto
descritto al punto successivo, è normalmente inferiore a qualche decina (nota 3)
- R1 ed R2 devono essere comprese indicativamente tra 1 kΩ e 100 kΩ.
Valori più grandi o più piccoli possono essere utilizzati solo
conoscendo nel dettaglio le caratteristiche elettriche
dell'amplificatore operazionale
- R3 non appare in nessuna formula e serve per proteggere l'ingresso
non invertente nel caso in cui Vin sia al di fuori degli Absolute
Maximum Ratings presenti
nei fogli tecnici. Il
suo valore può essere qualunque compreso tra 1 kΩ e 100 kΩ, ma
è buona norma sceglierlo pari al parallelo di R1 e R2;
qui una spiegazione.
- R4 non appare in nessuna formula ed è la resistenza di carico
in cui passa la corrente generata dall'amplificatore. Il suo valore non
deve essere troppo piccolo (tipicamente R4 > 1 kΩ) per non far superare alla corrente di
uscita il valore riportato nei
fogli tecnici. L'uscita
può anche semplicemente essere lasciata aperta (R4 = ∞) come nel
circuito della fotografia di apertura
- ampiezza ed offset di Vin devono essere scelti in modo tale che Vout
rimanga nei limiti descritti nei fogli tecnici e non
siano presenti distorsioni
armoniche significative
- la frequenza di Vin non deve essere troppo elevata per non generare
distorsioni di ampiezza. Un
valore tipico è 1 kHz
Il guadagno di tensione
Di seguito come devono apparire sullo schermo di un
oscilloscopio i
segnali di ingresso Vin (blu) e di uscita Vout (rosso) in un circuito
correttamente realizzato:
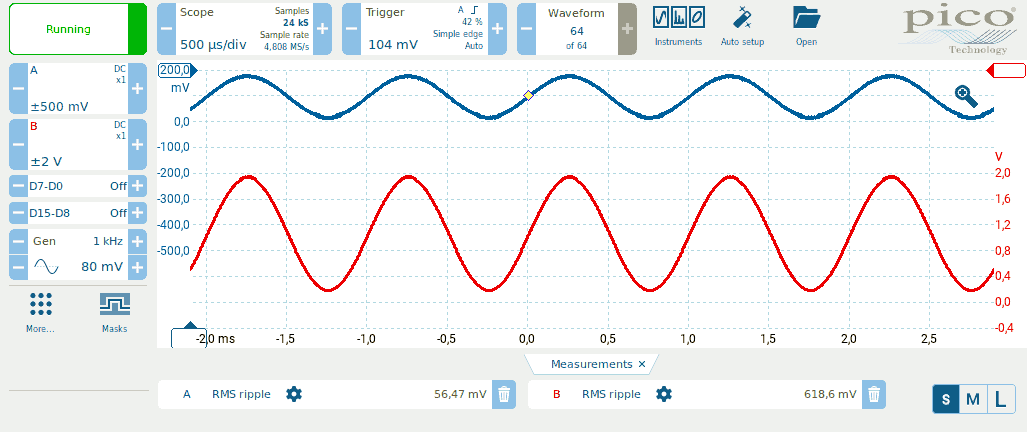
La prima verifica da fare è accertare l'assenza di
distorsioni
evidenti nel segnale di uscita: se l'ingresso è una sinusoide, anche
l'uscita lo deve essere!
Se l'uscita appare distorta o addirittura assente,
occorre verificare:
- eventuali errori di montaggio del circuito
- la corretta impostazione di frequenza, ampiezza ed offset del
generatore di segnali
- la presenza dell'alimentazione Vcc
- il corretto collegamento delle due sonde dell'oscilloscopio e del
cavo dal generatore di funzioni
- il funzionamento dell'amplificatore operazionale, sostituendolo con
un altro. Errati collegamenti possono facilmente danneggiare questo
componente, senza lasciare segni esteriori!
La misura fondamentale è il guadagno di tensione G che deve
coincidere con quanto calcolate con la formula. Ovviamente
possono essere presenti piccole differenze causate dagli
errori di misura oppure dalla tolleranza nel valore di R1 ed R2.
Conviene
misurare la tensione efficace della sola componente
alternata: a seconda dello strumento utilizzato essa è indicata come RMS
ripple oppure AC-RMS.
Per esempio nel screen-shot mostrato possiamo
leggere che G = 618.6 mV / 56.47 mV = 10,95.
Utilizzando la formula e conoscendo i valori di R1 e R2
effettivamente utilizzati (rispettivamente 10 kΩ e 1 kΩ) avrebbe dovuto
essere G = 11. La differenza (circa lo 0,5%) è compatibile con il fatto che
le due resistenze hanno una tolleranza dell'1%.
Attività 1: guadagno
- progettare un amplificatore con guadagno a scelta
compreso tra 5 e 20 e realizzarlo su breadboard. Utile scegliere gli
stessi valori già utilizzati per la simulazione
- impostare Vin per non avere distorsioni significative
- misurare la tensione efficace della sola componente alternata (RMS
ripple oppure AC-RMS) di Vin
e Vout
- calcolare il guadagno G e verificare che non sia troppo differente
dal valore previsto o dai risultati della
simulazione. Questo risultato è sostanzialmente indipendente dalla
scelta dell'amplificatore operazionale
Distorsione di ampiezza
La distorsione di ampiezza si
misura modificando la frequenza (nota 4) del
segnale di ingresso, analogamente a quanto mostrato nella pagina
Filtri passivi: simulazione. Le varie misure si riportano su un grafico semilogaritmico
che mostra come cambia
il guadagno di tensione al variare della frequenza; da questo grafico può essere ricavata la
massima frequenza di funzionamento dell'amplificatore,
cioè la sua banda. Non servono molte misure: l'amplificatore
mostrato si comporta infatti in modo simile ad un
filtro passa-basso
del primo ordine.
Attività 2: distorsione di ampiezza
Questa attività è simile a quella descritta per i
filtri passivi. È vivamente consigliato l'uso di un foglio elettronico!
- misurare il guadagno in unità logaritmiche utilizzando una sinusoide
con frequenza 1 kHz. Comodo riutilizzare quanto già fatto nell'attività
1
- aumentare la frequenza di Vin fino ad osservare una piccola diminuzione del guadagno. Misurare G in dB
- rispetto al punto precedente, aumentare di una decade la frequenza
di Vin. Misurare G in dB
- rispetto al punto precedente, aumentare di una ulteriore decade la
frequenza di Vin (nota 5). Misurare G in dB
- disegnare su
grafico semilogaritmico la risposta in frequenza dell'amplificatore
(nota 6)
- [Avanzato] misurare la banda
a -3 dB dell'amplificatore
- [Avanzato] raddoppiare il guadagno e ripetere questa attività
- [Avanzato] motivare il comportamento osservato al punto precedente
in base a quanto descritto
in
questo approfondimento
Distorsione armonica
Partiamo dallo stesso segnale usato
nell'attività 1 ed
aumentiamo moderatamente l'offset e/o l'ampiezza di Vin, fino ad
avere un'evidente distorsione del segnale di uscita.
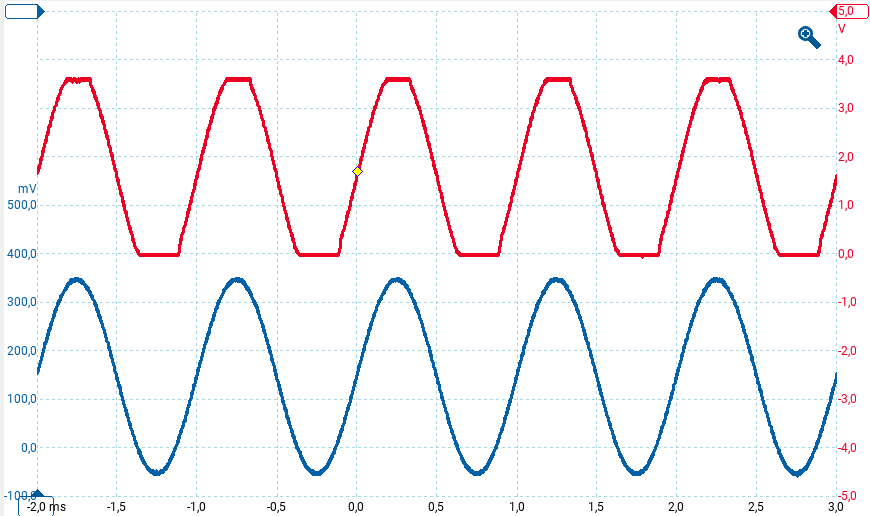
Visualizzare lo spettro del segnale di uscita su
scala logaritmica per poter verificare che si tratta
effettivamente di una distorsione armonica.
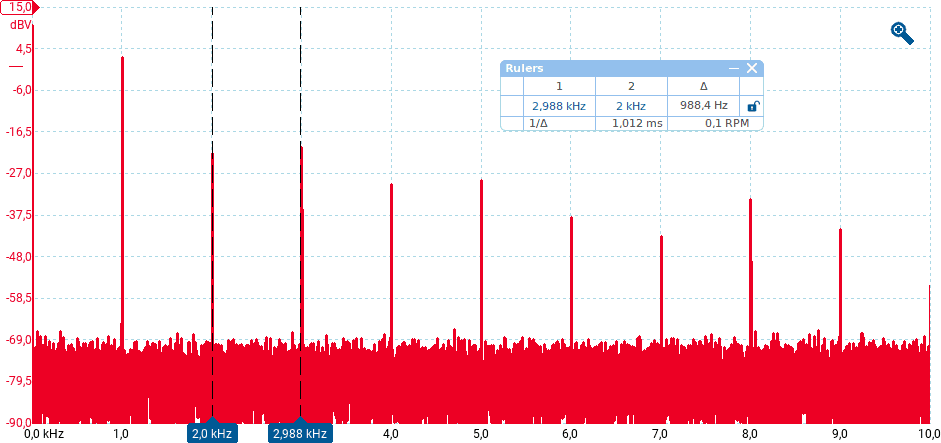
Sono
visibili la fondamentale (frequenza coincidente con quella del segnale di
ingresso, 1 kHz in questo esempio) e numerose linee a frequenza multipla intera. Si
nota anche il rumore che appare come un insieme casuale di linee spettrali
con ampiezza mediamente costante nella parte bassa del grafico.
Per le misure di
THD e
SFDR sono presenti apposite misure
automatiche:
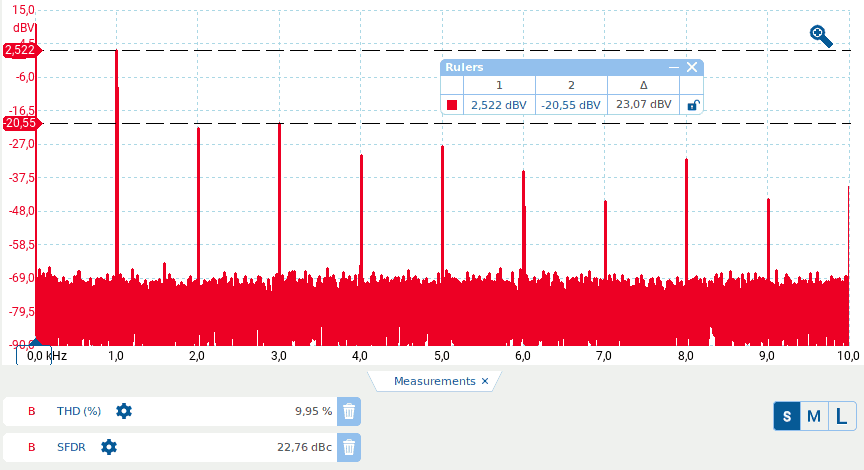
Attività 3: distorsione armonica
- aumentare l'ampiezza di Vin, fino ad ottenere in uscita un segnale
distorto
- misurare la massima e la minima tensione che l'uscita può assumere
nel dominio del tempo
- [Avanzato] motivare i valori misurati al punto precedente
in base ai fogli tecnici.
- visualizzare lo spettro del segnale di uscita
su scala logaritmica, limitando la massima frequenza visualizzata ad una
decina di volte la frequenza di Vin
- misurare con le apposite funzioni automatiche
THD e
SFDR
- [Avanzato] misurare SFDR
utilizzando i cursori ed applicando la definizione
- [Avanzato] misurare THD
utilizzando i cursori ed applicando la definizione (lungo...)
Note
- Possono essere utilizzati anche altri amplificatori, se adatti ad
essere usati con alimentazione singola di 5 V. Per inciso: NON va bene
il "mitico" LM721
- In genere è presente anche un paragrafo con alcune avvertenze (per
esempio sul fogli tecnici di Texas Instruments: 9 Power Supply
Recommendations). Tipicamente viene inserito un condensatore di
100 nF o più tra massa e Vcc
- Tutte le figure ed i calcoli usati in questa pagina rispettano
questo vincolo
- Purtroppo la nomenclatura non aiuta...
- Se il generatore di segnali lo permette, ovviamente. Altrimenti
usare il massimo valore possibile
- La risposta in frequenza è fortemente influenzata dall'amplificatore
operazionale utilizzato
Pagina creata nel novembre 2020
Ultima modifica: 19 gennaio 2025